
Credit image
A cura di Alexia Altieri
Articolo pubblicato su NewsCinema Magazine di Febbraio 2016 – Anno II – N.12 – [Pagg. 20-25] (download qui)
I primi di marzo uscirà al cinema Attacco al Potere – London has fallen.
Se il primo capitolo, Attacco al Potere – Olympus Has Fallen, vedeva la Casa Bianca presa d’assalto da estremisti nord-coreani decisi a colpire al cuore del potere a stelle e strisce, questa volta tocca alla capitale britannica essere nel centro del mirino.
Londra è stata spesso letta e riletta dagli occhi del cinema – location privilegiata di film dei generi più disparati. È stata nido d’amore, epicentro magico, palcoscenico di efferati omicidi e di impenetrabili misteri, ma soprattutto cuore pulsante dell’epoca vittoriana – in tutti i suoi sontuosi cambi d’abito: dal panciotto del diabolico barbiere di Fleet Street alla sfarzosa stoffa celeste che adorna l’abito vittoriano di Alice in Wonderland.

Londra romantica – Notting Hill, Roger Michell, 1999
Londra fa da sfondo all’appassionante storia d’amore tra l’elegante star hollywoodiana in trasferta e il libraio inglese, affascinante e anonimo, oltre che squattrinato. Julia Roberts e Hugh Grant si amano sul grande schermo e fanno sognare. Portobello Road è il cuore di Notting Hill – il caratteristico mercatino delle pulci e il negozio di libri di William Thacker, ne rappresentano l’attrazione principale. La città si fa teatro di un amore inedito: due mondi diversi quelli di Anna Scott e William, che si incontrano e scontrano in un’accecante e inaspettata passionalità dal retrogusto clandestino – i due si amano avvolti nell’oscurità dei giardini di Rosmead Gardens, al di là della recinzione che scavalcano senza remore e mano nella mano per le strade londinesi. 
Londra è amori intensi e cuori spezzati. Alla Waterloo Station, Gwyneth Paltrow da corpo al suo bivio, un macchinoso “what if” che ha seguito i moti del cuore della protagonista di Sliding Doors, tra le vie della città, per poi ritrovarla tradita, ferita – dalle schegge di una voce rotta dal pianto.
 All’8 di Bedale Street si trova il pub di fronte al quale lo stesso Hugh Grant prende parte a una rissa con Colin Firth – contendenti al cuore di Renée Zellweger, nei panni della goffa trentenne single-non-per-scelta Bridget Jones.
All’8 di Bedale Street si trova il pub di fronte al quale lo stesso Hugh Grant prende parte a una rissa con Colin Firth – contendenti al cuore di Renée Zellweger, nei panni della goffa trentenne single-non-per-scelta Bridget Jones.
I due volti della Londra vittoriana burtoniana:
 Londra aristocratica, superficiale e di facciata – Alice in Wonderland, Tim Burton, 2010
Londra aristocratica, superficiale e di facciata – Alice in Wonderland, Tim Burton, 2010
L’Alice burtoniana non è in sintonia con l’ambiente che la circonda: le regole imposte dall’etichetta e i cliché di buon costume le stanno stretti. La Londra vittoriana viene traslata a sinonimo di spazio claustrofobico, di una mentalità ristretta e sterile, che lascia ben poco spazio all’immaginazione.
 Londra plumbea, vendicativa e sanguinolenta –
Londra plumbea, vendicativa e sanguinolenta –
Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street, Tim Burton, 2007
Siamo completamente immersi nella foschia della Londra gotica della scenografia di Dante Ferretti, che si riversa nel nero fotografico di Dariusz Wolski – riflesso architettonico della favola nera abilmente inscenata e fatta propria dal regista. Burton deforma consapevolmente la messa in scena: viviseziona il corpo del film, inghiotte e rigurgita una società malata, incline al tradimento e al cannibalismo, e chiama a rapporto il suo attore feticcio – Johnny Depp.
Per interpretare Benjamin Baker, l’attore deve muoversi sul registro espressivo del tormento: azzera ogni ombra di civiltà e sprofonda nell’anima inquieta del diabolico barbiere – squarcia le tenebre di quell’abisso con la lama del proprio rasoio e lascia che fiotti di sangue scorrano nelle fenditure.
 Londra brutalmente violata – La vera storia di Jack Lo Squartatore, F.lli Allen e Albert Hughes, 2001
Londra brutalmente violata – La vera storia di Jack Lo Squartatore, F.lli Allen e Albert Hughes, 2001
“Sotto l’epidermide della storia, pulsano le vene di Londra. Questi simboli, la squadra, il pentacolo; anche un individuo profondamente ignorante e depravato come voi, avverte che essi sono pregni di energia e di significato. Quel significato sono io, sono io quell’energia. Un giorno gli uomini diranno, guardandosi indietro, che sono stato il precursore del XX secolo” – Jack Lo Squartatore.
Il quartiere di Whitechapel è passato alla storia – ma non nel modo per cui avrebbe voluto essere ricordato. Ci troviamo di fronte all’ennesima rappresentazione di Londra, quella torbida e profanata del 1888 – cuore della rivoluzione industriale, disseminata di pub frequentati da persone poco raccomandabili; viva nello scalpitio degli zoccoli di cavalli al traino di carrozze invisibili, immerse nella nebbia, e nel rumore molesto di violente scazzottate nei vicoli bui. Non solo scazzottate. A quei tempi, nell’oscurità della città si muoveva furtivo l’efferato omicida, più noto sotto l’inquietante pseudonimo di Jack The Ripper. Il primo corpo viene rinvenuto in Buck’s Row: una delle strade del triste quartiere dilaniato dalla povertà e dal degrado, teatro dei selvaggi assassinii di cinque prostitute. Il corpo viene a stento identificato: si tratta di Mary Ann Nichols.
Le pagine più macabre della storia londinese sono racchiuse idealmente nel London Dungeon Museum: dove vengono riprodotte teatralmente alcune tra le più micidiali scene del crimine che hanno marchiato a sangue la cultura popolare britannica – inutile dire che quelle relative a Jack Lo Squartatore sono tra le più richieste dai visitatori.
 Il lato oscuro di Londra e le sue perversioni – Dorian Gray, Oliver Parker, 2009
Il lato oscuro di Londra e le sue perversioni – Dorian Gray, Oliver Parker, 2009
La Londra del XIX secolo era un adorabile paradiso dei contrasti, dei vizi e delle virtù: una faccia della medaglia riluceva dei primi quartieri residenziali, delle prime classi benestanti, dei benpensanti e degli artisti di quell’epoca; il rovescio della medaglia vedeva invece una consistente fetta di popolazione riversata nelle baraccopoli, o vittima del degrado sociale e della perdizione– illegalità, prostituzione, oppio e alcol erano lo scomodo contraltare di un ostentato puritanesimo di facciata. Dorian Gray nasce dalla penna di Oscar Wilde e diviene manifesto di un estetismo decadente: il ritratto di Dorian Gray è il ritratto della stessa Londra – poiché sotto l’immortale bellezza e il satinato splendore si cela un’anima sudicia, sfigurata, diabolica.
 Londra misteriosa – Sherlock Holmes, Guy Ritchie, 2009
Londra misteriosa – Sherlock Holmes, Guy Ritchie, 2009
Siamo nuovamente nell’Ottocento e Londra ha conservato quell’aurea di mistero che le conferisce un fascino fatale. Anche Guy Ritchie gioca sulla logica del contrasto, trasportandoci nell’azione – in una sorta di braccio di ferro tra potere, forza fisica e acume – dipingendo deliziosi quadretti fatti di enigmi e metodica violenza a mani nude, seppur mantenendo sullo sfondo i fastosi palazzi delle istituzioni, accanto ai cantieri – testimoni della rivoluzione industriale, del progresso edile e tecnologico. E poi c’è il seducente richiamo dell’occulto, di ciò che non si può spiegare: un irresistibile Sherlock bohémien, che è solito rifugiarsi nel suo appartamento, al celebre 221B di Baker Street, per fare congetture e testare – stordito dai fumi dell’oppio ma pur sempre geniale – strane sostanze miracolose, con il suo fidato Watson al seguito, striscia per i labirintici cunicoli fognari dell’East End londinese, scova malfattori e sventa pericoli.
Londra magica – la saga di Harry Potter
La saga dedicata al maghetto più famoso di sempre ha dato ulteriore linfa vitale alla fama cinematografica internazionale della capitale britannica. Un giro di bacchetta, un incantesimo ed ecco che Londra si cambia d’abito e indossa il cappello a punta – anzi, il Cappello Parlante!
La Gringotts Bank, la sede del Ministero della Magia, Diagon Alley, il Millennium Bridge e più di tutti la stazione di King’s Cross sono entrati ufficialmente nell’immaginario collettivo di chi ama la saga di Harry Potter e – di conseguenza – ha amplificato il proprio amore per Londra. Il binario 9 ¾ di King’s Cross Station a Euston Road è stato addirittura ricreato, attraverso una targa e un carrello portavaligie idealmente incastrato nel muro, a metà tra il mondo reale e quello magico. Tutti i film di Harry Potter sono stati girati ai Leavesden Film Studios – i set sono oggi visitabili e quindi tappa fondamentale per tutti gli appassionati di Hogwarts.
 Londra vendicata – V per Vendetta, James McTeigue, 2005
Londra vendicata – V per Vendetta, James McTeigue, 2005
Londra è chiamata a prender parte all’ennesimo gioco di ruolo: McTeigue la prende tra le mani, la stropiccia, la deforma e le conferisce natura distopica. L’immagine che ne deriva è quella di un mondo futuristico in cui vige un regime totalitario, che si contrappone alla più radicale anarchia personificata nell’enigmatico Mr. V.
“Buona sera, Londra. Prima di tutto vi chiedo di scusarmi per questa interruzione”: afferma V, apparendo sullo schermo principale della celebre piazza londinese, Piccadilly Circus. La sua lotta per la libertà si articola tra Trafalgar Square, la Central Criminal Court, la stazione abbandonata della metropolitana – Aldwych Station e il Parlamento, per poi prorompere in un’esplosiva tabula rasa del centro dell’assolutismo britannico. Londra cade in ginocchio, e tutti stanno a guardare.
Londra action – saga di James Bond
Impossibile non pensare a Londra quando si parla dell’agente segreto più fascinoso di sempre. Basti parlare degli uffici della Universal Exports, o a Pierce Brosnan che cade da una mongolfiera e atterra sul tetto dell’Arena O2 nell’episodio “Il mondo non basta”, o il più recente Daniel Craig che corre a perdifiato per le strade di Whitehall in Skyfall. La città stessa sembra prender parte all’azione, le rive del Tamigi sembrano correre fianco a fianco all’agente 007. Si può dire che Londra rifletta esattamente la saga: non a caso, Ian Fleming, autore di James Bond, era solito frequentare il Dukes Bar – luogo di nascita del celebre Vesper Martini.
James Bond: “Un Vodka Martini”.
Barista: “Agitato o mescolato?”
James Bond: “Che vuole che me ne freghi?”
James Bond: “Penso che lo chiamerò Vesper”
Vesper Lynd: “Per via del retrogusto un po’ amaro?”
James Bond: “, perché una volta che lo hai assaggiato, non puoi più bere altro” – Casinò Royale.
 Attacco al potere – London has fallen, Babak Najafi, 2016
Attacco al potere – London has fallen, Babak Najafi, 2016
Ancora una volta Londra è stata scelta per presenziare una pellicola hollywoodiana. Quale maschera dovrà indossare? Quale ruolo sarà chiamata ad interpretare?
Il film uscirà nelle sale il 3 marzo – alla pellicola prenderanno parte Gerard Butler, Aaron Eckhart,



 Un demone che la maggior parte delle rivisitazioni, prima fra tutte quella animata dalla Walt Disney Pictures, esorcizza attraverso il ritratto innocente dell’eterno bambino che porta con sé orde di suoi coetanei nel giocoso microcosmo.
Un demone che la maggior parte delle rivisitazioni, prima fra tutte quella animata dalla Walt Disney Pictures, esorcizza attraverso il ritratto innocente dell’eterno bambino che porta con sé orde di suoi coetanei nel giocoso microcosmo. L’adattamento che ci mostra l’inedito volto demoniaco di quello che tutti conosciamo come “il difensore dei bambini” è la serie televisiva Once Upon A Time – in cui Peter Pan è un’ombra malvagia e l’Isola che non c’è assume le tinte dark e i toni noir dell’atmosfera da cui è avvolta, carica della tensione data dal regime oppressivo di Peter nei confronti dei Bambini Sperduti, ridotti a veri e propri schiavi. La cosa più curiosa e singolare di questa versione è la vera natura di Peter – il quale si scoprirà essere il padre di Tremotino, il personaggio più ambiguo e interessante della serie, che ha rinunciato al figlio pur di rimanere sull’Isola che non c’è. Insomma, siamo nuovamente di fronte a un rifiuto, ma questa volta di natura paterna.
L’adattamento che ci mostra l’inedito volto demoniaco di quello che tutti conosciamo come “il difensore dei bambini” è la serie televisiva Once Upon A Time – in cui Peter Pan è un’ombra malvagia e l’Isola che non c’è assume le tinte dark e i toni noir dell’atmosfera da cui è avvolta, carica della tensione data dal regime oppressivo di Peter nei confronti dei Bambini Sperduti, ridotti a veri e propri schiavi. La cosa più curiosa e singolare di questa versione è la vera natura di Peter – il quale si scoprirà essere il padre di Tremotino, il personaggio più ambiguo e interessante della serie, che ha rinunciato al figlio pur di rimanere sull’Isola che non c’è. Insomma, siamo nuovamente di fronte a un rifiuto, ma questa volta di natura paterna.




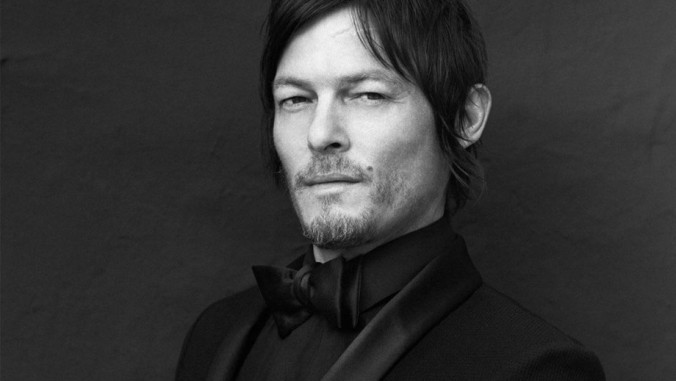










 ma con un’accezione dei termini nettamente in contrapposizione rispetto a quanto s’intende per il piccolo ed ingenuo Koda di Koda fratello orso (2003). Ben lontano, inoltre, dalla saggezza dell’intramontabile ed iconico Winnie The Pooh, il personaggio Disney dolce come il miele, e dalla buffa goffaggine del pasticcione Baloo di Il libro della giungla (1967) – Ted è pieno di vizi, quelli più riprovevoli degli esseri umani, anche se ora sembra aver messo la testa a posto …
ma con un’accezione dei termini nettamente in contrapposizione rispetto a quanto s’intende per il piccolo ed ingenuo Koda di Koda fratello orso (2003). Ben lontano, inoltre, dalla saggezza dell’intramontabile ed iconico Winnie The Pooh, il personaggio Disney dolce come il miele, e dalla buffa goffaggine del pasticcione Baloo di Il libro della giungla (1967) – Ted è pieno di vizi, quelli più riprovevoli degli esseri umani, anche se ora sembra aver messo la testa a posto …


 Entrambi quindi, personaggi riuscitissimi, con una marcia in più, che adorerei vedere a confronto in un ideale crossover in puro stile marvelliano – un irresistibile universo parallelo, in cui il sofisticato orsetto inglese potrebbe confrontarsi con l’impudico peluche americano …
Entrambi quindi, personaggi riuscitissimi, con una marcia in più, che adorerei vedere a confronto in un ideale crossover in puro stile marvelliano – un irresistibile universo parallelo, in cui il sofisticato orsetto inglese potrebbe confrontarsi con l’impudico peluche americano …







